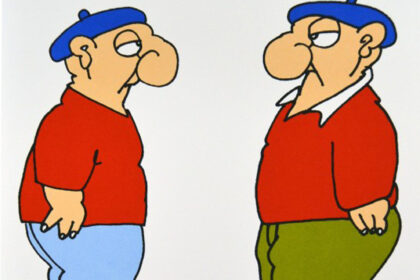Queste settimane di pioggia incessante e tempo gramo mi hanno fatto venire in mente questo dipinto. Si chiama Novembre ed è di Telemaco Signorini, quel fenomeno.
Tutto concorre a farci percepire l’indifferente crudeltà delle intemperie: l’umidità che scioglie il terreno, il vento freddo che sferza carni e vestiti, la poca luce che rattrista i colori, appiattisce i volumi e ammazza le ombre. Lo avvertiamo grazie a quel che viene rappresentato, ovviamente – il cielo gravido delle nubi ancora cariche, i solchi delle ruote dei carri riempiti d’acqua piovana, le vesti scosse dal vento – e ai colori, che si alternano fra il grigio violaceo del cielo e il bruno marcito del suolo, con quella lama di luce compressa, che fatica a farsi strada in mezzo a quei due blocchi. Ora, sui colori non mi sbilancerei troppo, perché il quadro non l’ho visto dal vivo (ohimé) e le riproduzioni che si trovano a stampa o in rete sono davvero troppo differenti fra loro. Il solito problema della riproducibilità tecnica, per dirla con Walter Benjamin.
Ad ogni modo, siamo nel 1870, lo Stato Pontificio è stato annesso al Regno di un’Italia in gran parte ancora rurale: di lì a poco, in Francia, artisti che diventeranno pietra angolare dell’intera storia della pittura canteranno di stazioni ferroviarie, di ponti su acque cristalline, di riunioni fra borghesi festanti, di viali alberati in città che pullulano di vita e di inquietudine.
D’altra parte Signorini proviene da un gruppo che si è occupato di raccontare l’epica del quotidiano. E, ecco, a me piace parecchio come lo fa in questo caso perché, al di là delle cose visibili, è come organizza la scena che permette un ulteriore livello di lettura, e che lo distingue dal suo precedente illustre: La traversata degli Appennini di De Nittis.
La massa delle nubi e quella della terra risultano equivalenti, e ciò è dovuto al fatto che la lama di luce di cui sopra divide il quadro in due metà uguali, sulla mediana lunga. La maggior parte degli elementi la accompagnano in questo andamento orizzontale: il crinale delle colline sullo sfondo, il muretto, la disposizione delle case in lontananza, le nubi stesse.
Questa insistenza sull’orizzontalità si trova spesso nei lavori dei Macchiaioli, e riporta a una dimensione concreta, assolutamente terrena. Il senso del vero, del reale, di cui in fondo parlano un po’ tutti quelli del gruppo.
Eppure l’impostazione ha qualcosa che travalica proprio quel reale, perché quel carro, parzialmente confuso con lo sfondo, è collocato al centro, sulla mediana verticale. E nel linguaggio visivo, linee verticali e orizzontali conferiscono staticità all’immagine; è proprio un discorso fisiologico, che proviene dal nostro sistema percettivo. Ora, in genere questo tipo di composizione e di direttrici sono molto usate nella rappresentazione dell’assoluto, dei temi sacri, delle rappresentazioni religiose, per le sue proprietà intrinseche. Ma qui gli elementi sono quanto di più reale si possa immaginare: il fango, la pioggia, il vento, la fatica.
Ecco allora che colpisce come, alla staticità dello sfondo si contrapponga il dinamismo del primo piano dato da quelle tracce di ruote che guidano il nostro sguardo seguendo una curva che dal margine basso conduce fino al carro posto al centro. E mentre le nuvole sembrano essere spinte dall’orizzonte verso destra e verso di noi, la curva che porta al carro prosegue in profondità oltre quel limite, in direzione opposta, a generare tensione e amplificare il senso del contrasto.
La magia sta qui: da un lato una sacralizzazione laica dell’esistente, della ripetizione dei cicli, dei gesti e delle stagioni. Una visione tardoromantica della Natura che ci guarda, indifferente, mentre ci affanniamo nelle nostre cose piccole eppure indispensabili. Dall’altro, l’avventura del vivere quotidiano, portata quasi ad atto eroico.
Poi io, sai, col culo al caldo ragiono bene.